Il fatto che i nostri sogni raccontino una parte di noi che non conosciamo, o che forse fingiamo di non conoscere, non è certo una novità. Ci sono fior di professionisti in prestigiosi studi del centro che, grazie a questa scoperta, si fanno pagare duecento euro all’ora per ascoltare i sogni altrui, accomodati su una poltrona in pelle, per poi tirare fuori un trauma infantile che sarebbe all’origine dei problemi del paziente, quasi sempre per colpa dei genitori.
Ora, di recente ho fatto un sogno che credo meriti di essere raccontato. Non a quei tizi delle poltrone in pelle di cui sopra, no grazie, al limite con me potrebbero tirare fuori la storiella dell’ansia prodotta dall’istinto di voler controllare tutto, che mal si concilierebbe con l’imprevedibilità della vita.
No, il mio sogno ho intenzione di raccontarlo a voi, che se vi va mi ascolterete gratis senza darmi responsi saccenti, se non vi va potete tornare a frugare su Amazon o Zalando, oppure sulla Gazzetta dello Sport o Youporn, a seconda dei vostri gusti (ho fatto un distinzione sessista? Sì, l’ho fatta. Denunciatemi alla Murgia se vi va).
Ebbene, qualche notte fa ho sognato di essere Batman. Complimenti all’autostima, starete pensando. In effetti mi rendo conto che come personaggio da impersonificare sia impegnativo, ma riflettiamoci un attimo: l’uomo pipistrello ha gadget fichissimi ed è un uomo super forzuto, però, alla fin fine, è un uomo. Non il figlio di qualche divinità nordica dotato di un martello mille usi che al Brico Center se lo sognano, e nemmeno un extraterrestre che vola e brucia tutto con la vista laser. Autostima sì, insomma, ma con moderazione.
Dunque, tornando al mio sogno, in veste di supereroe non dovevo confrontarmi con Joker e nemmeno sventare i piani criminali di Pinguino. Non c’erano. Ahimè non c’era nemmeno Cat Woman, che invece una ventina d’anni fa avrebbe monopolizzato le mie illusioni oniriche. Nel mio sogno affrontavo criminali, ma, come dire, si trattava della parte inutile della storia, come i dialoghi nei film di Rocky o le panoramiche turistiche finanziate dalle film commission nelle fiction Rai. I problemi erano altri.
In primis, parcheggiare la Bat Mobile. Sì, lo so, questo più che un sogno è un incubo, ma vivo a Bologna, la città dove i possessori di auto nella considerazione degli amministratori sono criminali da punire senza pietà, meno forse degli spacciatori ma di sicuro più dei vandali. Dove la parcheggi la Bat Mobile, che tra piste ciclabili, posti auto per disabili e riservati ai commercianti, ormai si trova parcheggio solo tra le 9 e le 10 del mattino? E se ci fosse bisogno di Batman in un’altra ora? Ce lo vedete Batman che aspetta il 13, per scoprire poi che in centro non ci arrivi più nemmeno con gli autobus, perché nella città più progressista d’Italia il centro deve essere lasciato libero ai tavolini?
Questa parte del sogno veniva risolta perché non usavo l’auto, punto, il mio inconscio lo risolveva così. Però si poneva una seconda questione. Una volta concluso l’intervento, dovevo tornare ad essere Bruce Wayne, perché mi attendevano a una riunione, o a una mostra, vai tu a sapere. Allora, dove lo riponi il travestimento di Batman? Di Clark Kent sappiamo che andava in giro sempre con il costumino di Superman sotto i vestiti, e gli evidenti problemi di traspirazione mettevano continuamente in crisi il suo rapporto con Lois Lane. Per non parlare della questione del mantello. Dove lo tieni nascosto quel mantello, birbante? Lo tiri fuori con un colpo di magia dal buco del… cilindro? Ma dove lo tiene il cilindro il signor Kent?
Insomma, dove lo ripone il suo armamentario Batman quando torna in abiti civili? Consideriamo che si tratta di un outfit piuttosto impegnativo da dismettere. Ti porti dietro un trolley? E se le orecchie a punta di sciupano? Uno zaino tipo camminatore? Può funzionare, però che ci fa un miliardario come Wayne con uno zaino sulle spalle? Non è credibile. Non sapere dove riporre la propria roba è un incubo, ammettiamolo.
Anche in questo caso il mio inconscio risolveva con l’ennesimo buco di sceneggiatura: mi ritrovavo infatti a riporre il costume nero nel cassetto, facendo attenzione a non esagerare che poi si sfondano, come fanno abitualmente persone a me care riponendoci più di quanto non possano contenere, sfidando la legge della impenetrabilità dei corpi.
Dopo di che qualcuno (un parente, ma non ricordo chi) apriva il cassetto e apriti cielo, che ci fa un costume di Batman qui?
È per Carnevale, rispondevo io prima di svegliarmi e tirare un sospiro di sollievo.
Con una consolazione: non sono un supereroe, o forse lo sono sempre stato senza rendermene conto.





 1. Se il calcetto è fatto bene rischi malattie veneree, altro che Covid
1. Se il calcetto è fatto bene rischi malattie veneree, altro che Covid
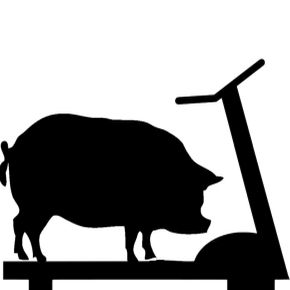
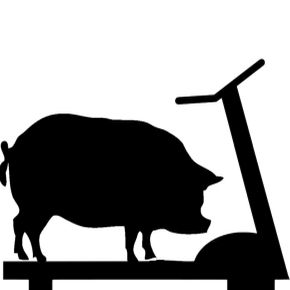 Ho frequentato negli anni diverse palestre (ma chi? Tu? Dici davvero? Staranno dicendo quelli che mi conoscono e conoscono il mio stato di forma). Sì, io, con risultati evidentemente insoddisfacenti. Anche perché mi alleno molto meno di quanto sarebbe necessario per ottenere un benché minimo traguardo. Ma il punto non è questo. Nel mio girovagare fra abbonamenti, ho frequentato palestre moderne, ambienti che sembravano usciti da un gangster movie anni cinquanta, micro-palestre ricavate nel seminterrato al posto della tavernetta, palestre universitarie, palestre in centro e nelle periferie ai margini della città. Non ho mai frequentato però una palestra con le vetrate, e ho paura che se questa tendenza continuerà, considerando che non sono un cliente fedele, prima o poi la palestra con la vetrata toccherà a me.
Ho frequentato negli anni diverse palestre (ma chi? Tu? Dici davvero? Staranno dicendo quelli che mi conoscono e conoscono il mio stato di forma). Sì, io, con risultati evidentemente insoddisfacenti. Anche perché mi alleno molto meno di quanto sarebbe necessario per ottenere un benché minimo traguardo. Ma il punto non è questo. Nel mio girovagare fra abbonamenti, ho frequentato palestre moderne, ambienti che sembravano usciti da un gangster movie anni cinquanta, micro-palestre ricavate nel seminterrato al posto della tavernetta, palestre universitarie, palestre in centro e nelle periferie ai margini della città. Non ho mai frequentato però una palestra con le vetrate, e ho paura che se questa tendenza continuerà, considerando che non sono un cliente fedele, prima o poi la palestra con la vetrata toccherà a me.