C’è un detto montanaro che ripete che a Monzuno anche le galline hanno i freni. Quest’immagine da sola racconta più di mille studi di orografia la natura di una terra a me cara che sta vivendo giorni difficili.
Contatto L., mi risponde che sta bene. La strada che conduce a casa sua si è sbriciolata come una millefoglie troppo cotta e per andare in ufficio percorre quattro o cinque chilometri a piedi, ma sta bene. Quando lavoravamo insieme era sempre la prima a sistemarsi dietro la scrivania, magari in questi giorni ci metterà un po’ di più. M. mi spiega che è tra i fortunati laggiù, tra i monti e il fiume, che ha ancora una casa integra e può ospitare i parenti cui è andata meno bene. Vicino a G. hanno fatto evacuare già alcune famiglie, si chiede se toccherà anche a lei. M. (non è la stessa persona di prima) dopo aver fatto il giro della zona rossa con i volontari osserva il suo bucato steso, lavato, impolverato e rilavato dalle piogge che aspetta che qualcuno lo raccolga, ma va bene.
L’unità di misura del benessere, dello stare bene andrebbe ricalibrata dopo il disastro che ha colpito la pianura, infangata e sommersa, e la montagna, che cade a pezzi, e non solo metaforicamente.
A queste persone sta letteralmente venendo meno la terra sotto i piedi, però ci sono e questo gli basta per rispondermi che dai, va bene. Non invito ad ammirarli ché non abbiamo bisogno di eroi, invito a ripensare ai nostri bisogni di elevati standard qualitativi, per i quali per stare bene ci servono sempre più tempo, spazio, risorse.
Qualcuno con un po’ di malinconia fa notare che anche nella disgrazia l’Appennino viene dopo. Tutto il mondo infatti ha testimoniato il dramma della Romagna, chissà in quanti sanno che anche da queste parti l’acqua si è portata via case, strade, ricordi. Per fortuna non vite.
Ma non c’è una classifica della tragedia, e se i frutteti devastati della bassa avranno un drammatico impatto sull’economia di queste terre, anche il fabbro di Vado non ha più niente con cui lavorare. La geografia del dolore non ha sfumature di intensità, chi perde tutto perde tutto a qualunque latitudine, e anzi in montagna forse ci mette anche di più a rimettersi in piedi.
I miei 24 lettori sanno che il maresciallo Luccarelli, protagonista di tanti miei racconti e di qualche romanzo, ha la caserma in Val di Setta. Dove ho lavorato diversi anni. I più attenti avranno capito che sorge proprio lì, a Vado, una delle zone più colpite dalle alluvioni del maggio 2023. Mi vengono in mente le parole di un ex sindaco che anni fa mi fece notare come Vado derivi da “guado”, e questo qualcosa dovrebbe insegnarci. Ma non ora, non è il momento. Guardate che vivere in una valle non è facile come negli spot televisivi. Fa freddo in inverno e caldo in estate. I percorsi di accesso non sono semplici. Ci vuole coraggio, per vivere in una valle, bisogna volerle bene. Anche perché quelle che noi chiamiamo Food Valley, Motor Valley, Data Valley, se prendete un atlante scoprirete che in realtà sono pianure che giocano con l’assonanza anglosassone.
Ebbene se il maresciallo esistesse davvero oggi sarebbe lì, nella valle, a spalare fango e terra. Chi gli dà voce più modestamente può, al massimo, fare quello che gli riesce meglio, mettere in fila parole che fissino i ricordi. Perché sono i ricordi le prime vittime di questi disastri. La lunga strada di curve e tornanti che da dalla provinciale dopo l’autostrada si arrampica su a Monzuno, e se svolti subito a destra passi davanti alla stazione e da lì raggiungi la piazza del paese, se la rivedi in foto non è più come la ricordavi. Non ti riconosci più nel percorso che facevi dalla delegazione comunale per arrampicarti fino alla stazione (sì, in Appennino tutto è un po’ sotto sopra, e le stazioni stanno in cima ai centri abitati) arrivando paonazzo a prendere il regionale delle 15. La fondovalle Savena che hai percorso in auto centinaia di volte, e quel mercoledì mattina hai pure esagerato con l’acceleratore ma cavolo, tua moglie ti aveva chiamato per dirti che le si erano rotte le acque, quella strada non si percorre più. In futuro, forse, chissà. Ora è strozzata come un sifone incrostato. È questo che fanno i disastri naturali, stravolgono lo spazio per alterare la tua cognizione del tempo. Questi eventi catastrofici che rivoltano l’orizzonte intorno a noi non cambiano solo le nostre storie: modificano per sempre la nostra percezione dei ricordi.
Una delle zone più martoriata dal fiume – dovremmo chiamarlo torrente ma la furia non era quella di un corso d’acqua minore – si chiama Blogna. Senza o.
Il segretario generale correggeva sempre quell’errore negli atti, finché non gli spiegarono che ormai quel refuso, quel retaggio dialettale si era fissato per sempre: quella frazione era per tutti Blogna. Anni fa, quando mi occupavo di servizi demografici, feci correggere con un atto di giunta la toponomastica di “via delle Quercie” con “via delle Querce”, perché le maestre venute da fuori acquietassero il loro sdegno ortografico di fronte a quella “i” di troppo, ma Blogna è rimasta così. Blogna non si tocca.
E invece. E invece non solo è stata toccata, ma adesso sarà inevitabilmente destinata a cambiare.
Si tornerà a vivere lì? E che vita è quella di chi ogni giorno rivede il mostro che ti è entrato in casa lasciandoti nudo con i tuoi rimorsi?
Difficile fare previsioni, difficile rimanere lucidi mentre si alza il coro sdegnato di chi ha sempre ragione e soprattutto ha qualcuno a cui dare una colpa. È colpa del Comune, della Città metropolitana, della Regione, del Governo. A seconda dei colori cambia il capro espiatorio su cui scaricare la propria frustrazione impotente. Ma intanto si spala, e non è che siccome sei di sinistra ciascuno spali secondo le proprie possibilità e siccome sei di destra allora premiamo quello che spala di più. Di fronte a questi eventi si spala e basta.
I den sänper la colpa alla C’muna mi spiegò un’amica nata lassù, abituata a fare pace con il mondo osservandolo dall’alto, nei pomeriggi dopo la scuola, tra le atmosfere rarefatte di Monte Venere.
Quell’amica se n’è andata troppo presto ma le sue parole sono rimaste: è sempre colpa del Comune (o degli altri enti, è uguale). È sempre colpa degli altri, il nostro stile di vita va bene così, possiamo continuare a consumare impunemente il pianeta, purché il sindaco tenga puliti i fossi.
Forza Monzuno, non dar retta ai saccenti che vomitano sui social la loro presunta superiorità, non sentirti nemmeno seconda perché da te o a Monterenzio non sono venuti ministri e presidenti europei. Le tue galline hanno i freni, si salveranno anche stavolta.
 Concludo con la mia personale immagine del disastro di questi giorni e della risposta di chi vive e lavora in Emilia Romagna. Una foto che ho rubato online al mio amico Gianluca.
Concludo con la mia personale immagine del disastro di questi giorni e della risposta di chi vive e lavora in Emilia Romagna. Una foto che ho rubato online al mio amico Gianluca.
Si tratta di uno smottamento a Monzuno e nemmeno dei più gravi, visto che sono venuti giù fianchi delle montagne come fette di pandoro inzuppate di latte. In confronto questa è una roba da ridere.
Ma questa foto mi piace perché quasi ce lo vedo il mio ex collega ignorante che non dorme da giorni, è corso su e giù a verificare, aiutare, indirizzare, e porca di quella miseria nemmeno ce l’ha più un cartello di divieto di accesso.
Perché ci sono più frane che cartelli in questi giorni nel mio amato Appennino. Ma il collega ignorante se ne frega delle difficoltà, tira fuori il cartello del mercato settimanale e la strada è chiusa.
Il giorno del mercato poi ci porremo il problema, adesso la risolviamo così.
Se fossimo tutti un po’ più come quegli operai che cercano di salvarci tra la pioggia e il fango e un po’ meno come quelli che dopo aver riposto la laurea di epidemiologia presa presso me stesso si scoprono ingegneri idraulici, ecco io penso il mondo sarebbe un posto migliore.
Forza Monzuno.
E sì, ci mancherebbe, forza Vado. Lo so che ci tenete. Rinforzate per bene quei pendii, non sia mai che quei gallinacci monzunesi con i freni più usurati vi finiscano in testa.
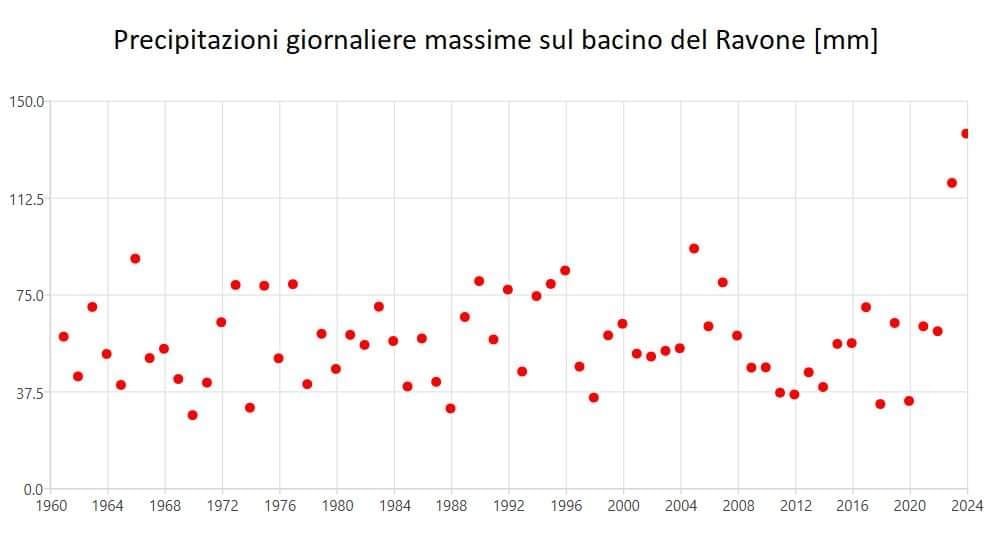
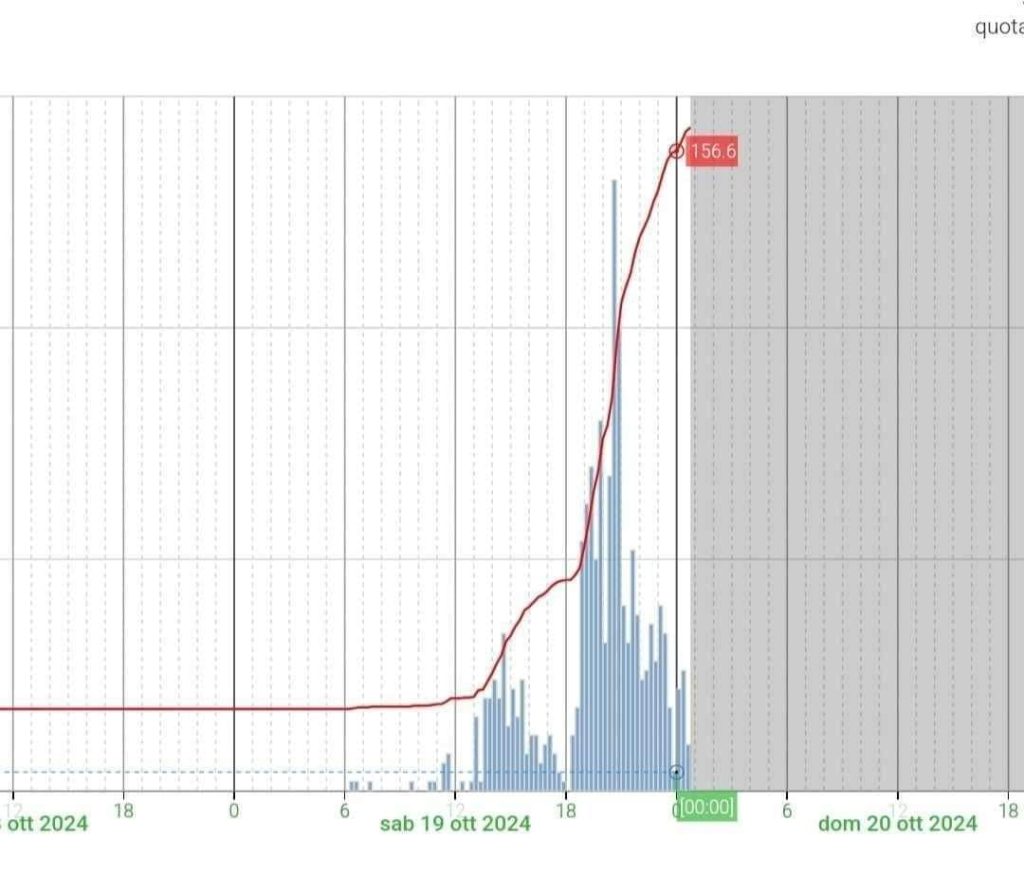

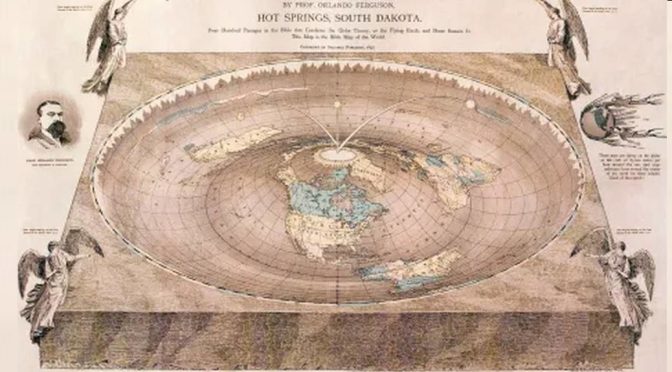





 Concludo con la mia personale immagine del disastro di questi giorni e della risposta di chi vive e lavora in Emilia Romagna. Una foto che ho rubato online al mio amico Gianluca.
Concludo con la mia personale immagine del disastro di questi giorni e della risposta di chi vive e lavora in Emilia Romagna. Una foto che ho rubato online al mio amico Gianluca.