Non sono uno di quei telespettatori snob che guarda solo serie televisive americane ad altissimo budget. Anzi, a volte i soldi e i grandi interpreti non bastano a coprire sceneggiature incerte, come nel caso del mediocre Obi-Wan Kenobi dell’universo Star Wars (come ci si può appassionare a una storia se si sa già quello che accadrà dopo?) oppure come per Secret Invasion, dove uno dei personaggi più carismatici dell’Universo Marvel, Nick Fury, viene coinvolto in un thriller cupo in cui a un certo punto, però, senza spiegoni online non si capisce davvero più nulla, tanti sono i salti nella trama, non tutti logici.
Al contrario: mi piacciono le serie tivù italiane, ho amato molto il Commissario Montalbano, attendo con ansia le nuove puntate di Rocco Schiavone e Imma Tataranni, trovo simpatico il protagonista di Macari, per una volta un giornalista e non il solito poliziotto sciupafemmine. Poi però mi imbatto in serie tivù di un livello qualitativo così discutibile da domandarmi se, come per il mitico Tano Boccia che girava usando i set dei peplum americani durante le pause pranzo, non le realizzino con gli scarti di altre produzioni. Le ultime due che ho guardato riguardano le mie due città del cuore, Bologna e Taranto, e in entrambi i casi lo sforzo per arrivare all’ultima puntata è stato davvero poderoso. Ho dovuto davvero insistere, convincermi che avevo tutte le capacità e il talento per andare fino in fondo senza dormire.
Si tratta di “Vivere non è un gioco da ragazzi” e di “Sei donne – Il mistero di Leila”.
I problemi che ho riscontrato sono simili, per cui comincio a pensare che ci sia un difetto nella progettazione di questi prodotti. Ma vediamo di procedere con ordine. Gli attori sono di prima qualità: Stefano Fresi e Claudio Bisio per Bologna, Maya Sansa e Isabella Ferrari per Taranto. E qui signori miei mi si alza il sopracciglio: ma davvero non ci sono attori bolognesi o tarantini in grado di rendere un po’ più credibile l’ambientazione? Una città non è fatta solo di palazzi e scenari. È fatta di persone e linguaggi. Nella prima fiction se non altro Stefano Fresi ci prova a parlare con un accento emiliano, nel secondo caso l’unica pugliese è la vittima che appare sì e no in tre scene. Passi che un poliziotto possa essere siciliano come nel caso di Alessio Vassallo, passi anche che il magistrato protagonista interpretato da Maya Sansa abbia vissuto a lungo a Roma (c’è un vago tentativo di giustificazione in merito nella sceneggiatura), ma perché suo figlio nato e cresciuto a Taranto è un romano de’ Roma, come per altro suo marito? E quanti veronesi – come un altro personaggio chiave – sono immigrati a Taranto, mannaggia alla miseria? Insomma, da questo punto di vista ci sono grosse carenze soprattutto nello sceneggiato tarantino: il casting segue scelte che ovviamente non sono quelle della verosimiglianza, ma delle capacità degli agenti di piazzare i loro clienti, ‘anvedi aho’!
Un mio rimpianto professore del liceo, Silvio Immune, trent’anni fa ci diceva che a causa della televisione avremmo tutti detto “So’ tarantino de Taranto”. Quanto aveva ragione.
L’altro aspetto comune è che ci sono diversi esterni, e questo va bene, ma sempre negli stessi duecento metri di città. Bologna è una città che offre una infinità di angoli cinematograficamente interessanti, nello sceneggiato tutto avviene sotto un portico del quartiere Barca, davanti a una villa sui colli e in via Zamboni. Per non parlare del mio amato Appennino: Monte Acuto Ragazza, borgo del Comune di Grizzana Morandi in cui sono ambientate alcune scene, meriterebbe una fotografia ricca e attenta. Invece vediamo a mala pena un albero, che avrebbe potuto tranquillamente essere un albero di qualunque colle di qualunque zona del mondo. Un albero.
Così come a Taranto tutto avviene sul lungomare, davanti alla Prefettura e in uno scorcio della città vecchia. Nessuno ha mai fatto jogging su quel lungomare, nessuno. Il marciapiedi è stretto, la strada molto trafficata, se scivoli e ti mettono sotto recuperano il tuo cadavere a San Vito. Direte: va bene, ma di questo te ne accorgi tu perché conosci della città. Anche Montalbano usciva di casa a Puntasecca, girava l’angolo per andare a prendere l’auto parcheggiata a Donna Lucata a 18 km e e si ritrovava alla fermata della corriera a Ragusa, che è a 30 km. Ma quella era una città, Marinella, immaginaria. Taranto c’è. Dirò di più: non tutti a Taranto hanno la casa e l’ufficio con vista sul mare. Pensa un po’ tu.
La risposta in questi casi credo sia semplice: bisogna ottimizzare i costi e ridurre il numero di set è un buon modo per farlo. Capisco. Ma un po’ di fantasia a sopperire i mezzi limitati non guasterebbe, dai. Muovetela quella macchina da presa, ogni tanto, osate con le luci, ho visto fotografare per le carte di identità con maggiore brio.
E veniamo al più grave dei difetti che caratterizza entrambi questi prodotti: l’enorme, insostenibile, massiccia noia che li caratterizza. La storia in entrambi i casi c’è: Fabio Bonifacci è un signor scrittore e uno dei migliori sceneggiatori che abbiamo in Italia, ma sembra che la regia si sia divertita ad allungare, slabbrare, diluire la vicenda bolognese che avrebbe potuto essere trascritta in un film di due ore e invece ne dura sei. Stessa sorte per il povero lavoro di Ivan Cotroneo che ha una idea che potrebbe appassionare, quella di raccontare le vicende di 6 donne che si intrecciano, ma è più annacquato di una Coca-Cola alla spina del McDonald’s. Primi piani, primi piani, primi piani. Sospiri. Primi piani. Maya Sansa che riesce a mantenere la stessa espressione per sei ore di girato, anche se qualche volte stringe gli occhi per far vedere quanto è cattiva o batte le palpebre lentamente quando il regista grida “più pensosa”. Il giovane protagonista della serie bolognese, poi, ha due espressioni come Clint Eastwood di Sergio Leone, con il cappello e senza. Solo che non ha nemmeno il cappello.
Abbiate pietà dello spettatore. Fateli muovere ogni tanto, questi attori. Sono film, anche se scritti per la televisione, non fotoromanzi con l’aggiunta dell’audio. Non voglio una sparatoria alla Quentin Tarantino, non voglio effetti speciali che non possiamo permetterci. Vorrei solo un po’ di mestiere, mica grandi spese, solo del ritmo per dare un po’ di pepe alla storia (quanto ci manca un Umberto Lenzi, oggi).
Bologna e Taranto meritano di meglio. Non siamo periferia dell’impero, non più.




 ali e contenuti ipertrofici h24, come dicono quelli che ne sanno. Andavamo allo stadio tutti insieme, dal mio indimenticabile “Erasmo Jacovone” di Taranto a San Siro, dall’Olimpico al Renzo Barbera. Poi tutti insieme rientravamo in auto sperando di fare in tempo per novantesimo minuto, per poi ritrovarci di fronte alla domenica sportiva, che faceva sì rivedere i goal, ma da angolazioni sghembe dietro la porta e con primi piani sul terzino che facevano tanto televisione di qualità.
ali e contenuti ipertrofici h24, come dicono quelli che ne sanno. Andavamo allo stadio tutti insieme, dal mio indimenticabile “Erasmo Jacovone” di Taranto a San Siro, dall’Olimpico al Renzo Barbera. Poi tutti insieme rientravamo in auto sperando di fare in tempo per novantesimo minuto, per poi ritrovarci di fronte alla domenica sportiva, che faceva sì rivedere i goal, ma da angolazioni sghembe dietro la porta e con primi piani sul terzino che facevano tanto televisione di qualità.
 E comunque il colorito di Carlo Conti non esiste in natura. Io c’avevo un Big Jim di quel colore, ma era perché lo lavavo con il sapone da bucato.
E comunque il colorito di Carlo Conti non esiste in natura. Io c’avevo un Big Jim di quel colore, ma era perché lo lavavo con il sapone da bucato.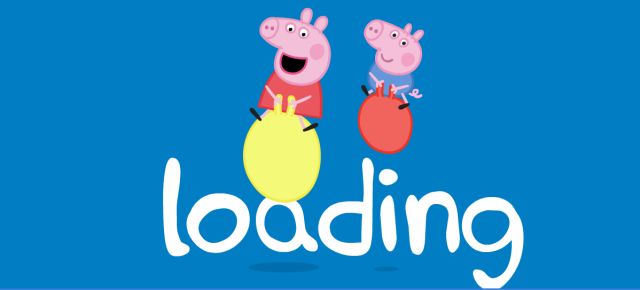
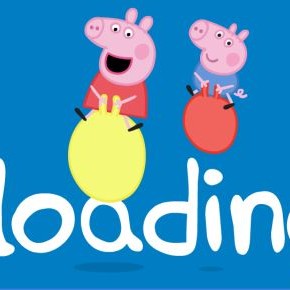

 Negli ultimi tempi in televisione è tutto un fiorire di cuochi, chef, maestri dei fornelli e compagnia cantante. Come ovvia conseguenze anche le conversazioni sempre più di frequente hanno a che fare con il cibo. Io non so cucinare, non nella accezione del termine che preveda un minimo di creatività e competenza. Eppure, nel mio meccanico e demenziale lavoro ai fornelli, mi sento di dare qualche consiglio talmente ovvio che io stesso, dopo averli scritti, ho pensato: ma dai, davvero non penserai che c’è qualcuno che…C’è, c’è, ve lo dico io.
Negli ultimi tempi in televisione è tutto un fiorire di cuochi, chef, maestri dei fornelli e compagnia cantante. Come ovvia conseguenze anche le conversazioni sempre più di frequente hanno a che fare con il cibo. Io non so cucinare, non nella accezione del termine che preveda un minimo di creatività e competenza. Eppure, nel mio meccanico e demenziale lavoro ai fornelli, mi sento di dare qualche consiglio talmente ovvio che io stesso, dopo averli scritti, ho pensato: ma dai, davvero non penserai che c’è qualcuno che…C’è, c’è, ve lo dico io.