Gli appassionati di calcio oggi seguono le partite di campionato praticamente dal venerdì al lunedì, persino all’ora di pranzo, con le giornate libere occupate da manifestazioni internazionali. Cari ragazzi miei che vi appassionate a questo sport come a me capitò più di trent’anni fa, non è sempre stato così. Quello che voi assaggiate è un vino talmente annacquato da risultare insipido, e mi domando come facciate a non esserne stufi (io per esempio lo sono).
C’era una volta la schedina: un gioco che con poche lire permetteva di sfidare la fortuna cercando di indovinare i risultati: la schedina fra le dita può cambiare la tua vita, cantava il mitico Toto Cutugno.
La schedina c’è ancora, almeno credo, ma è tutto il corredo intorno ad essere svanito. Intanto perché le partite si giocavano tutte in contemporanea, dalle 14,30 (orario spostato in avanti l’estate). Quindi in quei novanta minuti potevi sapere se avevi vinto o no, senza dover aspettare tre giorni. Poi perché la schedina era un rito collettivo, quello che manca alla società attuale parcellizzata tra mini schermi person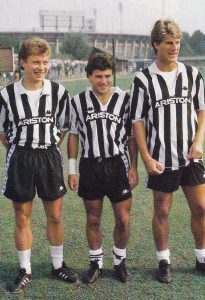 ali e contenuti ipertrofici h24, come dicono quelli che ne sanno. Andavamo allo stadio tutti insieme, dal mio indimenticabile “Erasmo Jacovone” di Taranto a San Siro, dall’Olimpico al Renzo Barbera. Poi tutti insieme rientravamo in auto sperando di fare in tempo per novantesimo minuto, per poi ritrovarci di fronte alla domenica sportiva, che faceva sì rivedere i goal, ma da angolazioni sghembe dietro la porta e con primi piani sul terzino che facevano tanto televisione di qualità.
ali e contenuti ipertrofici h24, come dicono quelli che ne sanno. Andavamo allo stadio tutti insieme, dal mio indimenticabile “Erasmo Jacovone” di Taranto a San Siro, dall’Olimpico al Renzo Barbera. Poi tutti insieme rientravamo in auto sperando di fare in tempo per novantesimo minuto, per poi ritrovarci di fronte alla domenica sportiva, che faceva sì rivedere i goal, ma da angolazioni sghembe dietro la porta e con primi piani sul terzino che facevano tanto televisione di qualità.
E io ancora me lo ricordo quel maledetto undici, un numero maledetto come il cinque e mezzo per i liceali o il ventinove per gli universitari, un sogno svanito in pochi attimi: il mio tredici che resisteva sino a pochi minuti allo scadere, poi due gol che ti facevano crollare dal mito del successo alla mediocrità di uno dei tanti che non ce la fa. Erano di solito le partite minori a rovinarti la festa, un pareggio casalingo della Triestina o peggio ancora una vittoria inattesa del Campobasso in C2 (e no, all’epoca la C2 non era una utilitaria francese). Non ricordo quanti undici ho collezionato, non tantissimi direi, ma abbastanza da farmi ancora ricordare la delusione.
Delusioni o gioie che derivavano dal nostro scandire il tempo tutti insieme, il dibattito la domenica sera dietro la parrocchia o ancora il lunedì mattina sull’autobus che ci portava a scuola. Perché noi non avevamo il supporto della tecnologia, ma eravamo parecchio social, eccome se lo eravamo.
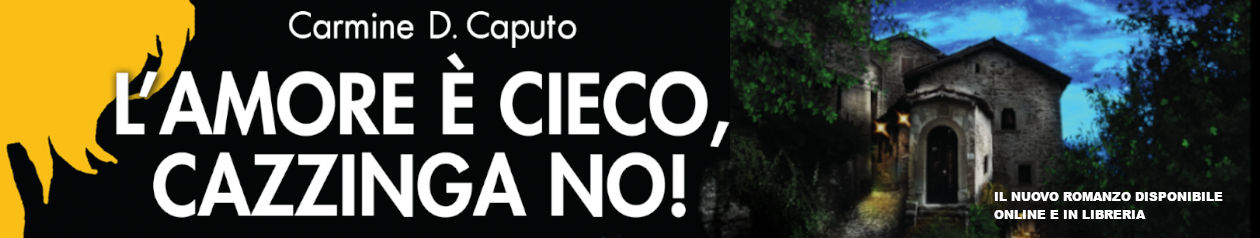


 La prima volta che vidi una cinepresa ero un bambino, mi sembrava un apparecchio strano che mio padre maneggiava con estrema cura, poi qualche volta c’era una grande festa e la proiezione dei “filmini”. La vidi poche volte perché non era sua, gliela prestarono, e in giro ce n’erano davvero poco. I “filmini” (nomignolo tra il riduttivo e l’affettuoso) erano privi di audio e tremolanti, ma evocavano un mondo al di là del pannello dove c’eravamo noi, o meglio i nostri simulacri. Duravano poco ma bastarono ad affascinarmi.
La prima volta che vidi una cinepresa ero un bambino, mi sembrava un apparecchio strano che mio padre maneggiava con estrema cura, poi qualche volta c’era una grande festa e la proiezione dei “filmini”. La vidi poche volte perché non era sua, gliela prestarono, e in giro ce n’erano davvero poco. I “filmini” (nomignolo tra il riduttivo e l’affettuoso) erano privi di audio e tremolanti, ma evocavano un mondo al di là del pannello dove c’eravamo noi, o meglio i nostri simulacri. Duravano poco ma bastarono ad affascinarmi.
 10) Prima di andare a cena da amici controlli le recensioni sui siti specializzati
10) Prima di andare a cena da amici controlli le recensioni sui siti specializzati
 C’è chi dice che i social network sono piazze “virtuali”. Come in piazza, o per taluni al bar, si fanno chiacchiere, si pontifica di questo e di quello, si dicono sciocchezze, si dà spazio a quello che definisco “il pensiero fesso”. Come similitudine la trovo piuttosto debole. E questo perché per arrivare in piazza devo vestirmi, prendere l’autobus, la bici o se abito in centro magari fare due passi, cercare qualcuno con cui chiacchierare. Tutto ciò richiede tempo, ed è giusto che sia così perché il tempo è il migliore filtro per bloccare le cavolate. Perché posso aver pensato che quel politico là proprio non capisce nulla, ma tra il momento in cui lo penso e il momento in cui finalmente vedo l’amico in piazza ho modo di elaborare il pensiero, adattarlo, sfumarlo. Magari ci ripenso e non la dico più, quella boiata. Poi qualche cavolata mi verrà fresca fresca di fronte all’amico, in estemporanea, e pazienza.
C’è chi dice che i social network sono piazze “virtuali”. Come in piazza, o per taluni al bar, si fanno chiacchiere, si pontifica di questo e di quello, si dicono sciocchezze, si dà spazio a quello che definisco “il pensiero fesso”. Come similitudine la trovo piuttosto debole. E questo perché per arrivare in piazza devo vestirmi, prendere l’autobus, la bici o se abito in centro magari fare due passi, cercare qualcuno con cui chiacchierare. Tutto ciò richiede tempo, ed è giusto che sia così perché il tempo è il migliore filtro per bloccare le cavolate. Perché posso aver pensato che quel politico là proprio non capisce nulla, ma tra il momento in cui lo penso e il momento in cui finalmente vedo l’amico in piazza ho modo di elaborare il pensiero, adattarlo, sfumarlo. Magari ci ripenso e non la dico più, quella boiata. Poi qualche cavolata mi verrà fresca fresca di fronte all’amico, in estemporanea, e pazienza.
 Alcuni anni fa lessi un libro intitolato “Tutto quello che sai è falso”. Lo feci soprattutto incuriosito dal lavoro dell’amico Roberto Vignoli, che allora aveva dato il via all’iniziativa della casa editrice Nuovi Mondi Media con alcuni soci. Il libro mi piacque – nonostante il titolo evidentemente forzato – perché invitava a osservare tante realtà apparentemente assodate con un punto di vista investigativo, diverso, opposto al cosiddetto “mainstream”. Già la quarta di copertina infatti invitava a porsi delle domande di fronte alle realtà spacciate come tali dai mass-media. I temi erano diversi: dall’uso degli psicofarmaci ai dubbi sull’aids, dal ruolo delle banche nella politica mondiale all’11 settembre. Quell’11 settembre che scatenò la voglia di indagare e capire di più che nei decenni precedenti sembrava essersi assopita. Sin dalla prima lettura trovai degli spunti condivisibili, altri mi lasciarono perplesso, su altri finii quasi per sorridere perché mi sembravano ipotesi davvero azzardate. Però non potevo non riconoscere che dietro quelle teorie c’era un metodo. C’era una raccolta di dati (contestabile, limitata, soggettiva, certo), c’era uno schema di analisi della realtà, c’era una sintesi (parziale, discutibile, forse errata). Ebbene, negli ultimi tredici anni purtoppo mi pare che le cose siano cambiate, ma non in meglio.
Alcuni anni fa lessi un libro intitolato “Tutto quello che sai è falso”. Lo feci soprattutto incuriosito dal lavoro dell’amico Roberto Vignoli, che allora aveva dato il via all’iniziativa della casa editrice Nuovi Mondi Media con alcuni soci. Il libro mi piacque – nonostante il titolo evidentemente forzato – perché invitava a osservare tante realtà apparentemente assodate con un punto di vista investigativo, diverso, opposto al cosiddetto “mainstream”. Già la quarta di copertina infatti invitava a porsi delle domande di fronte alle realtà spacciate come tali dai mass-media. I temi erano diversi: dall’uso degli psicofarmaci ai dubbi sull’aids, dal ruolo delle banche nella politica mondiale all’11 settembre. Quell’11 settembre che scatenò la voglia di indagare e capire di più che nei decenni precedenti sembrava essersi assopita. Sin dalla prima lettura trovai degli spunti condivisibili, altri mi lasciarono perplesso, su altri finii quasi per sorridere perché mi sembravano ipotesi davvero azzardate. Però non potevo non riconoscere che dietro quelle teorie c’era un metodo. C’era una raccolta di dati (contestabile, limitata, soggettiva, certo), c’era uno schema di analisi della realtà, c’era una sintesi (parziale, discutibile, forse errata). Ebbene, negli ultimi tredici anni purtoppo mi pare che le cose siano cambiate, ma non in meglio.
