Eh, signora mia, non è più la Bologna di una volta. Quando ero giovane io si poteva uscire tranquilli la sera, non c’erano mica queste brutte facce in giro. La città è cambiata, è peggiorata. Non la riconosco più. Se penso che quarant’anni fa…
Sostituite a Bologna il nome di qualunque altra città italiana, e vi ritroverete di fronte a uno dei più abusati dei luoghi comuni, quello che una volta si stava meglio. La diffusione di questi ragionamenti può essere interpretata in diversi modi. Secondo me, banalmente, non si ha nostalgia della città di quarant’anni prima; si ha nostalgia della propria vita di quarant’anni prima, si ha nostalgia della propria giovinezza.
Sabrina Leonelli questo errore non lo commette. La Bologna anni Ottanta è una Bologna vera, realistica, non diversa da tante città italiane dell’epoca, realtà dove lo spaccio di stupefacenti era sotto gli occhi di tutti. La diffusione di eroina in particolare era tale che non c’erano giovani, all’epoca, che non conoscessero un amico, un parente, un conoscente vittima di questa schiavitù. Io ricordo ancora, per esempio, l’attenzione che bisognava porre quando si attraversavano i giardinetti vicino alla stazione del mio paese, dove tra i cespugli non era difficile trovare siringhe usate.
La storia del romanzo è quella di un gruppo di amici (una volta si diceva “una comitiva”) che vivono nello stesso quartiere popolare e si incontrano nei dintorni di un muretto. Ecco, forse questa socialità in effetti si è persa: negli anni Ottanta e Novanta i ragazzi eleggevano una piazzetta, un angolo, un vicolo a loro residenza temporanea, lì si incontravano, interagivano, nascevano le prime storie d’amore, le prime gelosie.
Uno di questi amici vive un’esperienza dura che mette in crisi le sue certezze e intraprende quel percorso di discesa all’inferno che rappresentava e rappresenta l’uso di sostanza stupefacenti. L’autrice non fa sconti nel racconto dettagliato di cosa vuol dire essere in crisi d’astinenza, e spero che magari qualche ragazzo che dovesse leggere il libro possa avere un motivo in più per stare lontano da quella merda.
La rete di amicizie per fortuna è la nota di speranza di questa vicenda, visto che “i ragazzi del muretto” non abbandonano uno di loro nel momento del bisogno. In particolare la protagonista femminile mostra un coraggio e una generosità non da tutti, donando una colorazione rosa (oggi si direbbe romance) a un racconto drammatico.
Eh, signora mia, non ci sono più le comitive di una volta. Mi sa che questo è vero. I nostri figli atomizzati da smartphone e cuffie che creano rapporti effimeri e li isolano dal mondo esterno, non si incontrano più al muretto, ed è un peccato.
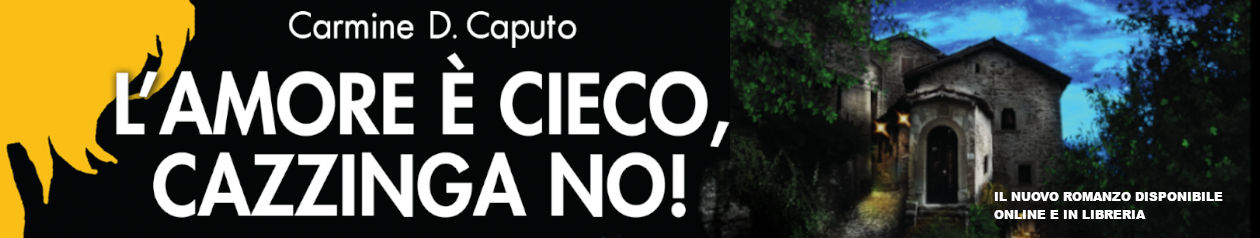



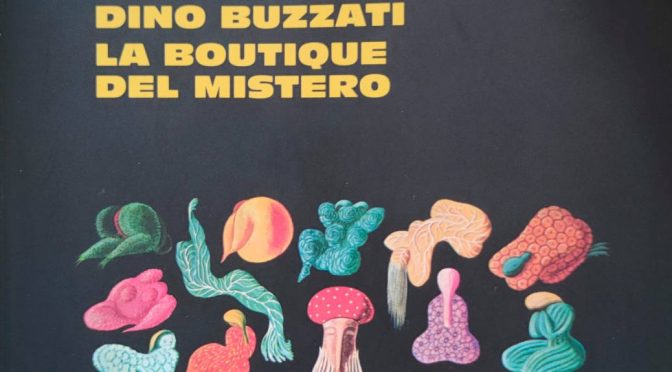
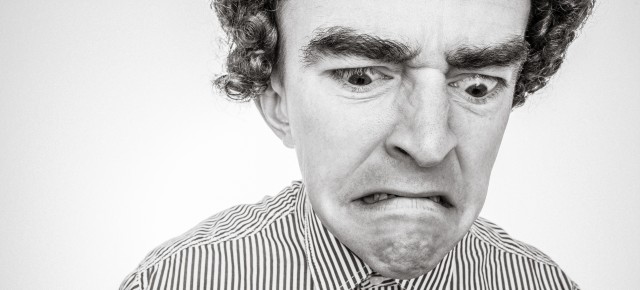
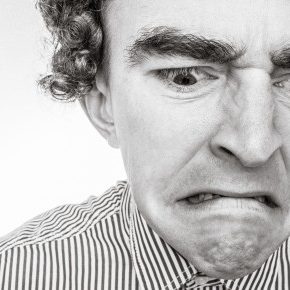 C’è quello che si lamenta della temperatura inappropriata del vino dopo aver mangiato in una tavola calda di campagna. Quello che denuncia lo scandalo di una televisione senza Sky in una pensione due stelle sul lungomare. Quello che fotografa inorridito la crepa nell’asse di legno che ha trovato sotto il divano del bed & breakfast, e la pubblica chiedendo giustizia.
C’è quello che si lamenta della temperatura inappropriata del vino dopo aver mangiato in una tavola calda di campagna. Quello che denuncia lo scandalo di una televisione senza Sky in una pensione due stelle sul lungomare. Quello che fotografa inorridito la crepa nell’asse di legno che ha trovato sotto il divano del bed & breakfast, e la pubblica chiedendo giustizia.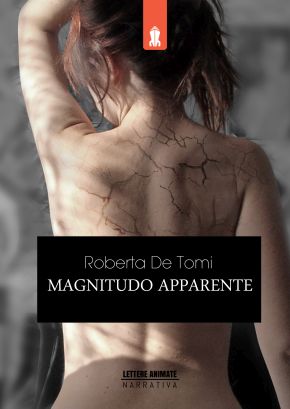
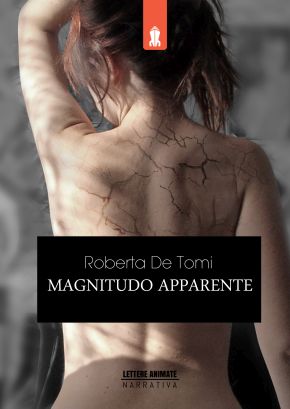 Sarà capitato a tanti adolescenti di trascorrere qualche settimana a casa degli zii, magari durante le vacanze estive. Proprio quello che succede a Nicolò, uno dei protagonisti di Magnitudo Apparente, romanzo di Roberta De Tomi edito da Lettere Animate Editore, che trascorre un’estate a Milano lavorando per lo zio che ha uno studio di contabilità. Un’occasione per vedere posti nuovi, fare un’esperienza lavorativa, uscire un po’ di casa.
Sarà capitato a tanti adolescenti di trascorrere qualche settimana a casa degli zii, magari durante le vacanze estive. Proprio quello che succede a Nicolò, uno dei protagonisti di Magnitudo Apparente, romanzo di Roberta De Tomi edito da Lettere Animate Editore, che trascorre un’estate a Milano lavorando per lo zio che ha uno studio di contabilità. Un’occasione per vedere posti nuovi, fare un’esperienza lavorativa, uscire un po’ di casa.